Come all'origine dell'aria (2010)

Bellissimo. Grande tensione. Grande apertura.
Gian Ruggero Manzoni
Appena si apre un libro si entra in un mistero: come se fossimo spinti dal vento, qualcosa ci muove in una nuova storia, in un nuovo incontro. La pagina che prima era bianca, ancora prima era semplice carta, ora è scritta: il foglio ha accolto la parola, ha cercato, a suo modo, di concederle spazio, di essere ospitale. La parola viva, il verbo, si è prestato a questa scrittura, ha raccolto se stesso in un guscio grammatico e si è donato alla storia.
Nell’aprire questo libro, l’apertura stessa si è rivelata molto più profonda di una semplice lettura di un testo. L’ho letto, si certo, l’ho riletto anche, ma è successo altro. Filippo, accanto a me, mi dice: “Leggimelo”. Ecco, mentre leggevo, il libro è diventato altro. Leggevo il libro al suo autore, o meglio: leggevo il poema al poeta. La poesia in un attimo aveva dato se stessa all’ascolto e si era liberata dall’affanno dell’inchiostro, come albatros fuggito dal mare nero. “Come all’origine dell’aria” è arrivato così.
Ci sono delle poesie che creano colori e spazi ampi, altre che portano suoni e tempi dalla vastità della vita…poche, in verità, sono quelle che specchiano la nascita ed il mistero dell’esistenza nella preziosità di un soffio leggero. Quando si incontrano questi versi nel costante bilico funambolico della nostra quotidianità, l’impatto è dolcissimo: si legge, nella parola, un tratto che l’occhio non vede e che spiazza, ci si ritrova disarmati e piacevolmente sorpresi dalla semplice complessità di una trasparenza. La sezione “Tu che sai”, anello di un cerchio che unisce l’evento de “Gli Incendi” al cuore delle “Figure senza erbario”, rapporta nel suo centro gli echi di queste ultime due: qui il tema è la Madre, la madre attesa fin dalla nascita. Qui, nell’attesa che è “dilatazione”, nei cenni e nelle trepidazioni di un’orma sfuggente, il dolore cerca la sua congiunzione ed anela ad un compimento. Questo luogo è il fulcro, il deserto che schiude altro:
“La mia attesa di te è dilatazione / del frammento superstite del cuore. / Nello slargo improvviso cede il margine / si assottiglia la difesa, si apre il cosmo / attraverso le minuzie del guardare. / Piccole cose, delicati spaventi / e come una certezza segreta / che viola l’incubo, che riempie l’incavo / e dentro la terra bruna trova riposo.”
La poesia è un’opera di solitudine, in primo luogo perché opera la solitudine e poi perché può nascere nella solitudine di ogni uomo. C’è la poesia alla nascita, un poesia nascente che riporta tutti noi alla profondità della vita ed al suo mistero, alla volontà di vivere ed alla necessità degli altri. Dalla solitudine della sua esistenza il poeta porta allo splendore della luce una parola per tutti: dalla notte tenebrosa della sua anima nasce il soffio della speranza comune. Per questo, come fossimo all’origine dell’aria, come fossimo in fasce, la solitudine è il memoriale del passaggio dalla morte alla vita, è il testamento della resurrezione.
Nella poesia di Filippo, nella buona ricerca della figura essenziale, “senza erbario”, senza catalogo o sistema, il passaggio del deserto è l’attraversamento esistenziale di una lacerante mancanza materna, di un calore sempre cercato ed atteso. Questo errare che per amore dell’amore si fa errore, suppone, presume, spera contro ogni speranza, corre al miraggio, sposta le lancette del tempo e prova a cavalcarle, è il significato della vita al di là di ogni significante. Sì, perché la poesia non porta ad altra poetica che all’esistenza stessa, a quella vita che anela all’origine e tende al compimento: la madre che ciascuno porta nel tessuto del suo esserci qui-ed-ora sporgente verso l’eternità.
La Parola in questa poesia trova finalmente la sua figura, il suo riferimento certo e saldo, l’origine del fuoco: Dio. Come scrive il profeta Isaia: “Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò” (Is 66,13). Egli si manifesta potente in modo tutt’altro che astratto, perché la prassi di Dio nella storia è l’evidenza di un’orma lasciata nel bianco terreno innevato:
“Vorrei che si capisse che è per grazia. / La pagina fu tramite fiorito / del respiro e non altro. Solamente / nell’alone del transito si illuminava. / Oltre e durante ci segnava un vento / che leviga le pietre, un’acqua dolce / che dà forma alle cose. / Io lo dicevo come il dito indica.”
Un matrimonio spirituale, così si potrebbe vedere questo libro. Un sigillo che corona una lunga e bellissima storia facendo promessa di amore duraturo e appassionato, donato in eterno: un fidanzamento cantato per molti anni e proteso nelle sue direzioni sia archeologiche che teleologiche, nella ricerca dell’origine e del compimento. Oggi, si potrebbe dire, il cerchio si chiude e si ricomincia dal fuoco dell’incendio per arrivare a quella Figura che, come Padre, ha amato la sua sposa fino a morire per lei, Madre, nel Figlio; fino a darle, fino in fondo, nella sua possibilità originaria, la libertà di amare e di risorgere in un tempo nuovo:
“Non sapevo / delle fessure che concede il legno / (l’aria vi penetrava per spifferi / insospettati). / Non sapevo che le parole / giocano sulla carta come bambine. / Il pianto copriva le zolle, / i fiori brillavano dietro la porta”.
Daniele Referza
“Ci sono case dove tutto il mondo pare farsi terrazza. La casa di Filippo a Macerata è spalancata sui tetti. Certe case hanno dimestichezza coi cieli, coi venti di sud-est che strattonano le tende, con gli uccelli e le loro gazzarre. In queste case viene più spontaneo dare del tu al mondo”, scrive Lucia Tancredi in una delle tre introduzioni a questa singolare raccolta. Il senso concreto di questa frase verrà compreso da ogni lettore quando saprà che Filippo Davoli, che si occupa dell’integrazione di immigrati extracomunitari, ospita nella sua casa nel centro di Macerata afghani, egiziani, africani e asiatici, a cui insegna la lingua italiana e prepara ad affrontare le difficoltà dell’inserimento nella nostra società. Ed è proprio ascoltando questi giovani che Andrea Ponso chiama “suoi figli”, che Filippo ha scritto alcune delle poesie inserite nel libro. Anche se, come scrive Gianfranco Fabbri, “Tu che sai è la sezione di questo libro che forse meglio rappresenta le dinamiche esistenziali più intime del suo autore”, penso che anche nelle “voci” raccolte dai suoi amati ragazzi ci sia molto dell’autore e ne cito una a conferma di un modo tipico dell’autore di guardare al mondo e alla propria parola:
quando parli ai ragazzi mi apri il senso / anche della mia vita. A casa ripeto / ogni suono e mi piace. Penso che è bello / continuare nel sogno di ciò che dice / il mormorare della voce, il sussurro / della memoria che guarda.
Conosco Filippo ormai da una vita e rivedo i suoi occhi di bambino attento, curioso di tutto, in ascolto della voce altrui e del proprio rifletterla. Non per niente uno dei suoi libri si intitola Alla luce della luce, e anche qui una poesia dice:
Portami il canto lieve della luce / una traccia, un sigillo, un’opportuna / calma… Rendimi, tu che sai.
Mi pare di poter chiudere, appropriatamente, con un’annotazione di Andrea Ponso: “La struttura della lingua poetica di Davoli (…) è un codice che rischia fino in fondo la sua semplicità, che poi altro non è che complicità e vicinanza con il lettore, qualunque esso sia, una lingua che si fa accogliente per dare davvero voce agli altri”. E l’accoglienza di questo poeta non è astratta:
ho saputo dagli altri che a casa tua / si sta bene perché tu ci vuoi bene. / Posso venire anch’io insieme agli altri / a farmi un poco volere bene da te?
scrive l’immigrato Edison quasi all’inizio del libro che a sua volta aspetta la nostra accoglienza.
Franco Loi
Filippo Davòli, licenziando Come all'origine dell'aria (L'arcolaio 2010), ci consegna la propria vita nel momento di massima consapevolezza, nell'attimo in cui, guardandosi indietro, ha finalmente trovato il nome che tenga insieme biografia e archetipo. Seguendo il polemos eracliteo, secondo cui la realtà non è che la concordia di opposte tensioni, e coniugandolo con motivazioni cristiane, Davoli chiama padre – sulla scorta di Christian Bobin (citato in epigrafe a "Gli incendi", la prima sezione, ed autore certo affine alla sensibilità di Filippo) – chi sa "porsi al servizio di ciò che accade senza pretendere di esserne il padrone", e chiama madre la carne stessa dell'amore, ogni essere capace di rendere vivo l'abbraccio del padre-madre originario, quel Dio diventato veramente uomo sul Calvario, ossia l'abbandonato, il derelitto, l'orfano capace di gridare la propria insopportabile condizione dai quattro cantoni del mondo, quella croce che tiene gli opposti e li rende promessa generante di ricongiunzione con il Principio. Le tre sezioni che compongono questo libro, trinitarie per vocazione, dicono tutta la fatica di Davoli, uomo di fede, per accudire i propri "figli" sans papier, giovani che si raccontano per momenti emblematici, con una strategia retorica non molto lontana da quella messa in atto da Fabiano Alborghetti ne L'opposta riva (LietoColle, 2006). Se tuttavia ad Alborghetti premeva anzitutto il risvolto sociologico, a Davoli interessa focalizzare il legame fra sé e ogni singola vita che professionalmente incontra, lavorando egli con gli immigrati. Così facendo, dà voce ad un cristianesimo attivo, manzoniano, speso tutto fra i deboli, che pone al centro, come scrive Andrea Ponso, la "relazione con l'alterità, con il suo dono e la concretezza anche quotidiana" (p. 84). Ecco dunque in che senso biografia ed archetipo s'incontrano. E lo stesso accade nella seconda sezione ("Tu che sai"), anche se l'urgenza biografica (l'essere stato abbandonato in culla), con la conseguente scissione originaria, che mette in primo piano il tentativo di un dialogo sia con la madre biologica (persa nel nulla) e sia con la madre adottiva, è inevitabilmente dominante. Eppure anche questa sezione è pervasa di religiosità, di quell'amore cui sopra accennavo e che qui si connota quasi di modulazioni mistiche, in un tu in cui le due madri si confondono, ombre luminose della Vergine Maria nella sua vita terrestre, tormentata. "Figure senza erbario", l'ultima parte di un libro che tiene insieme dieci anni di scrittura, è quella più scopertamente attraversata dalla preghiera, con versi francescani nell'attenzione a celebrare la natura benedetta, ma più introflessi ("la solitudine / ha bisogno di un canto sussurrato"). L'anaforico incipitario "Vorrei" non solo allinea questi ultimi testi nell'ambito del sacro, ma apre ad un desiderio tutto umano, legato alla funzione della poesia nel mondo, nell'auspicio che in esso le parole brucino "arse dentro l'amore". Ed è esattamente questo che si respira in Come all'origine dell'aria: la passione per una parola che sveli il soffio divino presente in ogni uomo, soffio di un Dio che è amore, dono, nell'accezione cristiana – ma anche, oserei direi, coerente con il piglio anticapitalistico di Jean Baudrillard, laddove questi lo intende come dissipazione dell'egocentrismo, realizzazione di sé attraverso il sacrificio della proprietà che il sé moderno presuppone.
Stefano Guglielmin, "blanq de ta nuque", domenica 12 settembre 2010
Gian Ruggero Manzoni
Appena si apre un libro si entra in un mistero: come se fossimo spinti dal vento, qualcosa ci muove in una nuova storia, in un nuovo incontro. La pagina che prima era bianca, ancora prima era semplice carta, ora è scritta: il foglio ha accolto la parola, ha cercato, a suo modo, di concederle spazio, di essere ospitale. La parola viva, il verbo, si è prestato a questa scrittura, ha raccolto se stesso in un guscio grammatico e si è donato alla storia.
Nell’aprire questo libro, l’apertura stessa si è rivelata molto più profonda di una semplice lettura di un testo. L’ho letto, si certo, l’ho riletto anche, ma è successo altro. Filippo, accanto a me, mi dice: “Leggimelo”. Ecco, mentre leggevo, il libro è diventato altro. Leggevo il libro al suo autore, o meglio: leggevo il poema al poeta. La poesia in un attimo aveva dato se stessa all’ascolto e si era liberata dall’affanno dell’inchiostro, come albatros fuggito dal mare nero. “Come all’origine dell’aria” è arrivato così.
Ci sono delle poesie che creano colori e spazi ampi, altre che portano suoni e tempi dalla vastità della vita…poche, in verità, sono quelle che specchiano la nascita ed il mistero dell’esistenza nella preziosità di un soffio leggero. Quando si incontrano questi versi nel costante bilico funambolico della nostra quotidianità, l’impatto è dolcissimo: si legge, nella parola, un tratto che l’occhio non vede e che spiazza, ci si ritrova disarmati e piacevolmente sorpresi dalla semplice complessità di una trasparenza. La sezione “Tu che sai”, anello di un cerchio che unisce l’evento de “Gli Incendi” al cuore delle “Figure senza erbario”, rapporta nel suo centro gli echi di queste ultime due: qui il tema è la Madre, la madre attesa fin dalla nascita. Qui, nell’attesa che è “dilatazione”, nei cenni e nelle trepidazioni di un’orma sfuggente, il dolore cerca la sua congiunzione ed anela ad un compimento. Questo luogo è il fulcro, il deserto che schiude altro:
“La mia attesa di te è dilatazione / del frammento superstite del cuore. / Nello slargo improvviso cede il margine / si assottiglia la difesa, si apre il cosmo / attraverso le minuzie del guardare. / Piccole cose, delicati spaventi / e come una certezza segreta / che viola l’incubo, che riempie l’incavo / e dentro la terra bruna trova riposo.”
La poesia è un’opera di solitudine, in primo luogo perché opera la solitudine e poi perché può nascere nella solitudine di ogni uomo. C’è la poesia alla nascita, un poesia nascente che riporta tutti noi alla profondità della vita ed al suo mistero, alla volontà di vivere ed alla necessità degli altri. Dalla solitudine della sua esistenza il poeta porta allo splendore della luce una parola per tutti: dalla notte tenebrosa della sua anima nasce il soffio della speranza comune. Per questo, come fossimo all’origine dell’aria, come fossimo in fasce, la solitudine è il memoriale del passaggio dalla morte alla vita, è il testamento della resurrezione.
Nella poesia di Filippo, nella buona ricerca della figura essenziale, “senza erbario”, senza catalogo o sistema, il passaggio del deserto è l’attraversamento esistenziale di una lacerante mancanza materna, di un calore sempre cercato ed atteso. Questo errare che per amore dell’amore si fa errore, suppone, presume, spera contro ogni speranza, corre al miraggio, sposta le lancette del tempo e prova a cavalcarle, è il significato della vita al di là di ogni significante. Sì, perché la poesia non porta ad altra poetica che all’esistenza stessa, a quella vita che anela all’origine e tende al compimento: la madre che ciascuno porta nel tessuto del suo esserci qui-ed-ora sporgente verso l’eternità.
La Parola in questa poesia trova finalmente la sua figura, il suo riferimento certo e saldo, l’origine del fuoco: Dio. Come scrive il profeta Isaia: “Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò” (Is 66,13). Egli si manifesta potente in modo tutt’altro che astratto, perché la prassi di Dio nella storia è l’evidenza di un’orma lasciata nel bianco terreno innevato:
“Vorrei che si capisse che è per grazia. / La pagina fu tramite fiorito / del respiro e non altro. Solamente / nell’alone del transito si illuminava. / Oltre e durante ci segnava un vento / che leviga le pietre, un’acqua dolce / che dà forma alle cose. / Io lo dicevo come il dito indica.”
Un matrimonio spirituale, così si potrebbe vedere questo libro. Un sigillo che corona una lunga e bellissima storia facendo promessa di amore duraturo e appassionato, donato in eterno: un fidanzamento cantato per molti anni e proteso nelle sue direzioni sia archeologiche che teleologiche, nella ricerca dell’origine e del compimento. Oggi, si potrebbe dire, il cerchio si chiude e si ricomincia dal fuoco dell’incendio per arrivare a quella Figura che, come Padre, ha amato la sua sposa fino a morire per lei, Madre, nel Figlio; fino a darle, fino in fondo, nella sua possibilità originaria, la libertà di amare e di risorgere in un tempo nuovo:
“Non sapevo / delle fessure che concede il legno / (l’aria vi penetrava per spifferi / insospettati). / Non sapevo che le parole / giocano sulla carta come bambine. / Il pianto copriva le zolle, / i fiori brillavano dietro la porta”.
Daniele Referza
“Ci sono case dove tutto il mondo pare farsi terrazza. La casa di Filippo a Macerata è spalancata sui tetti. Certe case hanno dimestichezza coi cieli, coi venti di sud-est che strattonano le tende, con gli uccelli e le loro gazzarre. In queste case viene più spontaneo dare del tu al mondo”, scrive Lucia Tancredi in una delle tre introduzioni a questa singolare raccolta. Il senso concreto di questa frase verrà compreso da ogni lettore quando saprà che Filippo Davoli, che si occupa dell’integrazione di immigrati extracomunitari, ospita nella sua casa nel centro di Macerata afghani, egiziani, africani e asiatici, a cui insegna la lingua italiana e prepara ad affrontare le difficoltà dell’inserimento nella nostra società. Ed è proprio ascoltando questi giovani che Andrea Ponso chiama “suoi figli”, che Filippo ha scritto alcune delle poesie inserite nel libro. Anche se, come scrive Gianfranco Fabbri, “Tu che sai è la sezione di questo libro che forse meglio rappresenta le dinamiche esistenziali più intime del suo autore”, penso che anche nelle “voci” raccolte dai suoi amati ragazzi ci sia molto dell’autore e ne cito una a conferma di un modo tipico dell’autore di guardare al mondo e alla propria parola:
quando parli ai ragazzi mi apri il senso / anche della mia vita. A casa ripeto / ogni suono e mi piace. Penso che è bello / continuare nel sogno di ciò che dice / il mormorare della voce, il sussurro / della memoria che guarda.
Conosco Filippo ormai da una vita e rivedo i suoi occhi di bambino attento, curioso di tutto, in ascolto della voce altrui e del proprio rifletterla. Non per niente uno dei suoi libri si intitola Alla luce della luce, e anche qui una poesia dice:
Portami il canto lieve della luce / una traccia, un sigillo, un’opportuna / calma… Rendimi, tu che sai.
Mi pare di poter chiudere, appropriatamente, con un’annotazione di Andrea Ponso: “La struttura della lingua poetica di Davoli (…) è un codice che rischia fino in fondo la sua semplicità, che poi altro non è che complicità e vicinanza con il lettore, qualunque esso sia, una lingua che si fa accogliente per dare davvero voce agli altri”. E l’accoglienza di questo poeta non è astratta:
ho saputo dagli altri che a casa tua / si sta bene perché tu ci vuoi bene. / Posso venire anch’io insieme agli altri / a farmi un poco volere bene da te?
scrive l’immigrato Edison quasi all’inizio del libro che a sua volta aspetta la nostra accoglienza.
Franco Loi
Filippo Davòli, licenziando Come all'origine dell'aria (L'arcolaio 2010), ci consegna la propria vita nel momento di massima consapevolezza, nell'attimo in cui, guardandosi indietro, ha finalmente trovato il nome che tenga insieme biografia e archetipo. Seguendo il polemos eracliteo, secondo cui la realtà non è che la concordia di opposte tensioni, e coniugandolo con motivazioni cristiane, Davoli chiama padre – sulla scorta di Christian Bobin (citato in epigrafe a "Gli incendi", la prima sezione, ed autore certo affine alla sensibilità di Filippo) – chi sa "porsi al servizio di ciò che accade senza pretendere di esserne il padrone", e chiama madre la carne stessa dell'amore, ogni essere capace di rendere vivo l'abbraccio del padre-madre originario, quel Dio diventato veramente uomo sul Calvario, ossia l'abbandonato, il derelitto, l'orfano capace di gridare la propria insopportabile condizione dai quattro cantoni del mondo, quella croce che tiene gli opposti e li rende promessa generante di ricongiunzione con il Principio. Le tre sezioni che compongono questo libro, trinitarie per vocazione, dicono tutta la fatica di Davoli, uomo di fede, per accudire i propri "figli" sans papier, giovani che si raccontano per momenti emblematici, con una strategia retorica non molto lontana da quella messa in atto da Fabiano Alborghetti ne L'opposta riva (LietoColle, 2006). Se tuttavia ad Alborghetti premeva anzitutto il risvolto sociologico, a Davoli interessa focalizzare il legame fra sé e ogni singola vita che professionalmente incontra, lavorando egli con gli immigrati. Così facendo, dà voce ad un cristianesimo attivo, manzoniano, speso tutto fra i deboli, che pone al centro, come scrive Andrea Ponso, la "relazione con l'alterità, con il suo dono e la concretezza anche quotidiana" (p. 84). Ecco dunque in che senso biografia ed archetipo s'incontrano. E lo stesso accade nella seconda sezione ("Tu che sai"), anche se l'urgenza biografica (l'essere stato abbandonato in culla), con la conseguente scissione originaria, che mette in primo piano il tentativo di un dialogo sia con la madre biologica (persa nel nulla) e sia con la madre adottiva, è inevitabilmente dominante. Eppure anche questa sezione è pervasa di religiosità, di quell'amore cui sopra accennavo e che qui si connota quasi di modulazioni mistiche, in un tu in cui le due madri si confondono, ombre luminose della Vergine Maria nella sua vita terrestre, tormentata. "Figure senza erbario", l'ultima parte di un libro che tiene insieme dieci anni di scrittura, è quella più scopertamente attraversata dalla preghiera, con versi francescani nell'attenzione a celebrare la natura benedetta, ma più introflessi ("la solitudine / ha bisogno di un canto sussurrato"). L'anaforico incipitario "Vorrei" non solo allinea questi ultimi testi nell'ambito del sacro, ma apre ad un desiderio tutto umano, legato alla funzione della poesia nel mondo, nell'auspicio che in esso le parole brucino "arse dentro l'amore". Ed è esattamente questo che si respira in Come all'origine dell'aria: la passione per una parola che sveli il soffio divino presente in ogni uomo, soffio di un Dio che è amore, dono, nell'accezione cristiana – ma anche, oserei direi, coerente con il piglio anticapitalistico di Jean Baudrillard, laddove questi lo intende come dissipazione dell'egocentrismo, realizzazione di sé attraverso il sacrificio della proprietà che il sé moderno presuppone.
Stefano Guglielmin, "blanq de ta nuque", domenica 12 settembre 2010
padano piceno (2003)

padano piceno è libro di luoghi, esistenti o immaginari, di riflessioni, d’armistizio anche, con un universo solo apparentemente “altro”: s’attesta su diverse quote sostenuto da un’ottima uniformità stilistica che pone ogni pagina come fotogramma e sintesi, dove i piani della realtà sono un’energia imprevista, frammenti di tempo sospeso (ma com’è gialla la luce di questo tramonto / delicato e opprimente, com’è lontana / la tua voce che mi parlava…).
Tutto accade con naturalezza: il motivo centrale è l’antieroicità dell’accadimento osservato però con nitidezza (… io penso che ci si cerca per blandirsi / almeno un poco, sibilando come fa il neon / per la paura di spegnersi o per la gioia / di aver varcato il silenzio un’altra volta), ed il bilanciamento avviene tra parentesi, allusivamente, tra astrazioni parsimoniose e progressioni.
L’evidente pacatezza impressionista della tastiera linguistica di Filippo trova ampiezze - benché sobrie e rigorose - tra valenze evocative, specie nelle pause, nelle cesure e nella partitura asciutta non scevra di ritmica (...Là si vive / fianco a fianco, in rispetti che si ignorano / tra le altre specie in superficie, là / ogni frammento di esistenza vale / tutta la verità ) e punti di arrivo inerpicati nella soluzione verso una inversione alternativa, fortemente comunicativa e nuovamente d’esplorazione. Ogni poesia è - a dire il vero - un risultato di molti incontri situazionali e rivelatori.
La capacità di Filippo è trasformarli in “racconti” in “situazioni”, con svolte solo apparentemente impoetiche: come graffiti, graffi su di un muro. Ogni testo diviene qualcosa che deve esistere perché esistito prima di divenire testo. Privilegiato il percorso fedelmente aderente alla realtà, con mobilità di segni, di solchi da scoprire, di memorie, contatti, di incontri: Ci diamo un appuntamento fittizio, perché ciò che importa / è sapersi già in viaggio da una cornetta / all’altra, a cerchio sul mondo. In fondo il nostro / è un incontro in volo: un brulicare / di pause, di fioriti silenzi. Ci congiunge / misterioso un fluire nel sogno.
Fabiano Alborghetti
Tutto accade con naturalezza: il motivo centrale è l’antieroicità dell’accadimento osservato però con nitidezza (… io penso che ci si cerca per blandirsi / almeno un poco, sibilando come fa il neon / per la paura di spegnersi o per la gioia / di aver varcato il silenzio un’altra volta), ed il bilanciamento avviene tra parentesi, allusivamente, tra astrazioni parsimoniose e progressioni.
L’evidente pacatezza impressionista della tastiera linguistica di Filippo trova ampiezze - benché sobrie e rigorose - tra valenze evocative, specie nelle pause, nelle cesure e nella partitura asciutta non scevra di ritmica (...Là si vive / fianco a fianco, in rispetti che si ignorano / tra le altre specie in superficie, là / ogni frammento di esistenza vale / tutta la verità ) e punti di arrivo inerpicati nella soluzione verso una inversione alternativa, fortemente comunicativa e nuovamente d’esplorazione. Ogni poesia è - a dire il vero - un risultato di molti incontri situazionali e rivelatori.
La capacità di Filippo è trasformarli in “racconti” in “situazioni”, con svolte solo apparentemente impoetiche: come graffiti, graffi su di un muro. Ogni testo diviene qualcosa che deve esistere perché esistito prima di divenire testo. Privilegiato il percorso fedelmente aderente alla realtà, con mobilità di segni, di solchi da scoprire, di memorie, contatti, di incontri: Ci diamo un appuntamento fittizio, perché ciò che importa / è sapersi già in viaggio da una cornetta / all’altra, a cerchio sul mondo. In fondo il nostro / è un incontro in volo: un brulicare / di pause, di fioriti silenzi. Ci congiunge / misterioso un fluire nel sogno.
Fabiano Alborghetti
14 solitari in 7 poeti del Premio Montale (Crocetti, 2002)

Ad apertura di pagina ha fermato la nostra attenzione per il suo talento aforistico, per l'economia del verso, la concentrazione dell'immagine e del senso: Eppure si tratta di vita. Non c'è nient'altro, e poi: E' dolce anche sparire, // io credo. Fulminante e materna l'ipotesi sulla morte nella poesia: Forse proprio quando meno lo sospetti / il fiume si apre in falcate di cenere... e indimenticabile la contemplazione illuminante della vecchiaia, con il suo prezioso chiasmo finale: Invecchiare così è morire viendo. / Essere morti vivendo è un'altra cosa.
Quando un poeta come Davoli scende in profondità, tutto, comunque, irradia vitalità e giovinezza.
Maria Luisa Spaziani
Quando un poeta come Davoli scende in profondità, tutto, comunque, irradia vitalità e giovinezza.
Maria Luisa Spaziani
Una bellissima storia (Stamperia dell'arancio, 2000)
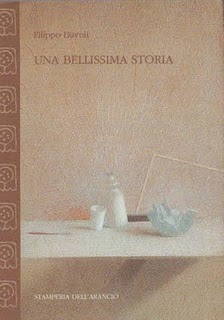
Dopo avere letto Una bellissima storia ed esserne rimasto piacevolmente impressionato, ho voluto incontrare l'autore. Una volta è naufragato lui, dal mare d'acque, a Cagliari. Una seconda volta sono andato io a Macerata: entrambi abbiamo così gustato i sapori e aspirato i profumi dei nostri luoghi, sicché le pagine si sono animate di preziosi dettagli d'esistenza. Da Macerata a Recanati, dove Filippo mi ha accompagnato con la piacevolezza affabulatoria di cui è dotato, il cammino è breve su per le strade che circondano i colli dolci e ondosi, come Filippo ama dire, del maceratese. Due mari, allora, uno d’acque e l'altro d'erbe, il mio e il suo, che ci accomunano nel movimento corposo e morbido delle parole. Con Filippo, sul Colle dell'Infinito, ho compreso - direi meglio, preso, afferrato e portato via con me - quel viatico straordinario che è l'ultimo verso dell'Infinito.E il naufragar m'è dolce in questo mare: le parole covano nella sensibilità, filtrano dalla ragione ma radicano profondamente nel loro lento sedimentare sui luoghi del nostro vivere. Non avevo mai pensato a quanta vita dei colli recanatesi, che Leopardi aveva dinanzi agli occhi, palpitasse in quel verso.
La poesia di Filippo è così: è vita, prima di tutto. E poi è parola, una parola che si incarna - profeticamente - per ritornare alle cose, agli uomini, al dialogo fitto ed agli incontri. "La vita è l'arte dell'incontro", ama dire Filippo citando Vinicius de Moraes. Aggiungerei io, parafrasando, che per Filippo anche la poesia, in quanto strumento, in quanto accidente che al poeta è toccato in sorte d'avere, è arte dell'incontro. Banale sillogismo ci porta ad inferire che senza la vita, senza il movimento talvolta amaro delle cose, la poesia è parola vuota, fine a sé stessa, che non si incarna.Incontrare gli altri, comunicare, è spesso faticoso. Implica uno spostamento non solo fisico ma anche - soprattutto - interiore. E l'immagine del cammino, della ricerca che conduce all'incontro che poi va coltivato col dono sacro della parola è carissima a Filippo. Anzi, direi che sostanzia la ragione stessa del suo ultimo libro, Una bellissima storia, dove già per sé la storia è un percorso lungo le proprie strade e per i propri luoghi. Luoghi che non sono mai concepiti come vuoti, solitari; sono intensamente abitati da mille destini che Filippo incrocia: dediche, citazioni, riferimenti alla quotidianità di una comunità rendono i suoi versi una bellissima città a misura d'uomo.
Vorrei qui fare un breve cenno, per spiegarmi e restituire l'immagine che ho avuto nel vedere i collages di Filippo, proprio alle sue composizioni figurative, dove si insiste su qualche immagine reale o appartenente alla nostra tradizione pittorica usandola come sfondo, per "incollarvi" o riprodurvi con la tecnica del fotomontaggio profili a lui noti, sagome e ritratti di persone che hanno avuto un tratto significativo nella sua vita e che rappresentano la ricerca delle sue radici. Le piazze, i locali, le stanze vuote si animano della sua gente. Della sua comunità.La medesima impressione possono darci i suoi versi con una magica suggestione evocativa e pittorica. Il suo camminare diviene tuttavia il nostro camminare, ché diversamente la poesia non si incarnerebbe. Un cammino attraverso il tempo e lo spazio, una storia di incontri, perdite, nostalgie, miracoli imprevisti e gesti minimi che poi divengono emblematici. Così, anche il tema dell'incontro può avere il duplice valore della magia e dell'incanto da una parte, della sofferenza e del distacco dall'altra. Gli incontri sono imprevisti, ci capitano tra capo e collo, proprio come i libri. Succedono, accadono senza che noi ne possiamo prevedere i tempi e la scansione. E tutto si basa su un sottilissimo e tenue filo di immagini, profumi, gesti evocativi. Un semplice tratto, una svista.
Tra simili ci si conosce al volo. / Si riconosce un tratto, una svista, / i sillogismi del cuore. Specialmentese / se poi un'ansia di coprire / fa scoprirele carte, svelare i sogni, / diciamo così. Ma è un gioco per pochi intimi e forse / una tacita complicità destinata / al suo privato oblio. / That's all.
Tutta la densità del primo verso, vitalissimo e dal profumo intenso di una invocazione, si riverbera poi nella malinconia e quotidianità del finale. That's all. Questo è tutto: come per chiudere una questione e rimandare tutto al prossimo pensiero, alla prossima poesia. Come uno scatto improvviso, uno struggimento che è già divenuto volontà di proseguire la bellissima storia verso un altro incontro. That's all.
Il rapporto con il tempo è basato su un ambiguo atteggiamento di amore e odio. Filippo lo insegue dentro l'immobilità paradossale del suo trascorrere, fra le storie dell'esistenza e la storia personale dell'esistere: un tempo immobile, catturato nell'immagine del locale dove si gioca a biliardo e che immaginiamo avvolto nella semioscurità delle luci soffuse, tra i fumi e le persone che maneggiano la stecca da biliardo, magari un bicchiere poggiato sulla cornice del tavolo.
Se Ti incontrassi davvero al Bar del tempo / forse pioverei nei tuoi occhi / ma mi risucchierebbe di là / la sala da biliardo e la fumea / che ne colora le ore. Io giocare non so: / preferisco guardare / l'attimo in cui la canna / schiocca sulla biglia color crema, / afflitto come sono dalla smania / di frenare gli istanti, di calarmi / dentro la vita (Tu che faresti?) / forse in quegli occhi Tuoi / potrei arrestare l'ansia di questa corsa / senza finale / con le tappe intermedie che si accavallano / se solo Tu abbandonando il bicchiere / apparissi per caso sull'uscio / a cercarmi di nuovo. / Ecco, allora direi / che forse non era grave scivolare / sul piano verde tra i birilli scomposti / se Tu venissi a chiedermi di andare / perché s'è fatto tardi.
La sala da biliardo, allora, diviene un bar assoluto del tempo, diventa un luogo altro e fuori dalla misura crono-logica, per seguitare a giocare coi paradossi di Davoli, un luogo nel quale si cerca con smania di frenare gli istanti (un altro paradosso: la frenesia della non frenesia); si spera, almeno si spera, di vedere comparire sull'uscio la figura di un altro incontro, in un'atmosfera cinematografica dall'intenso tratto figurativo: talché ci rimane impresso, assurdamente, il volto di un'assenza. La figura che si spera di vedere ma non si vede: se tu venissi a chiedermi di andare / perché si è fatto tardi.
Affascinante questa capacità della parola di legarci all'assenza di un'immagine, più che all'immagine stessa (se tu venissi: ma non ci sei). In questo caso, cioè, l'andare via perché si è fatto tardi è proseguire lungo il filo di una bellissima storia con niente altro che la speranza di non essere più soli. Proseguire il cammino con il desiderio di un incontro e con la speranza che l'incontro ci possa essere, al bar del tempo e in un'altra poesia. In questo caso, davvero esemplare della poesia - o, se è ancora concesso usare tale terminologia, della poetica - di Filippo, c'è il racconto della contraddizione fra il desiderio di vivere nel mondo e la difficoltà ad esserci, a sincronizzarsi con i suoi movimenti; l'evocazione di uno scotto da pagare alla lucidità con cui si osservano le cose ma che impedisce però di aderirvi completamente. Il divario tra la contemplazione e la materialità del vivere, se si vuole: o ancora meglio, il contrasto tra chi il mondo lo vive da dentro, senza poterne valutare l'interezza, e chi invece è capace di uno sguardo sintetico, da un osservatorio privilegiato e complessivo, ma che il più delle volte, non potendo viverci dentro, subisce l'esistere come la condizione di un disadattato. Ma Al bar del tempo può ancora accadere l'evento dell'incontro; c'è lo scatto miracoloso di un accadimento che poi è sempre una ricerca e una speranza che tale accadimento si verifichi, più che la sua realtà e certezza. Ed entriamo, per l'ingresso principale, dentro un altro tema di Filippo, quello di una profonda intensa religiosità che anima molte sue pagine, direi anzi tutte, anche quando non s'affaccia con evidenza. Una religiosità che da una parte gli fa sentire l'altissimo valore e la responsabilità impliciti nel fare poesia, dall'altra tributa al poeta la capacità profetica dell'intermediazione tra il qui ed ora e l'Altro come altrove da qui. La ricerca tra gli uomini diventa anche una ricerca con gli uomini per una possibilità di riscatto più ampia. Con le parole che Filippo Davoli ama dire spessissimo: la poesia è un accessorio, è strumento. Non può esistere fuori dal mondo e dalla vita che lo anima.
Ecco allora il senso radicalmente profetico della parola evocativa che galleggia nel bar del tempo: dice Davoli di aver voluto esplicitamente dialogare con il libro omonimo Il bar del tempo di Davide Rondoni: "nel testo che dà il titolo al libro l'autore accompagna Gesù Cristo al bar. Qui ho sentito affiorare un'ipotesi di incontro ulteriore nello stesso bar" (vedi nelle note in calce al libro di Davoli).
Ebbene, sono sempre contrario alle note d'autore nei libri, perché mi danno l'impressione di una certa nostalgia che l'autore stesso ha per il proprio testo, quasi di volontà a non staccarsene del tutto nel consegnarlo ai lettori. Preferisco sempre l'ambiguità, preferisco che l'autore non dia segnali e che lasci scoccare dall'incrocio tra la sua anima e quella del lettore la scintilla dell'interpretazione. Tuttavia, qui, la spiegazione di Filippo ha un senso imprevisto, perché crea, come in abisso, in una vertigine di senso, l'occasione per un molteplice incontro: tra Davide Rondoni e Cristo; tra Filippo e Davide Rondoni (o meglio, tra le poesie dell'uno e dell’altro); tra Filippo e Cristo (o il desiderio di Cristo); tra Filippo e noi e così via ricostruendo i circoli che, dal più stretto al più esterno e ampio, vanno allargandosi poco a poco come cerchi nell'acqua. E vanno restituendoci il senso della poesia che è incarnazione del verbo. La poesia diviene allora parola che ha messo immediatamente in contatto l'uomo con l'uomo e l'uomo con sé stesso e con la propria ricerca del senso che ha il vivere (o il continuare a vivere: l'incontro con Cristo evoca forse il senso di una stanchezza per il tempo materiale?) e il medesimo fare poesia.
Giovanni Cara
La poesia di Filippo è così: è vita, prima di tutto. E poi è parola, una parola che si incarna - profeticamente - per ritornare alle cose, agli uomini, al dialogo fitto ed agli incontri. "La vita è l'arte dell'incontro", ama dire Filippo citando Vinicius de Moraes. Aggiungerei io, parafrasando, che per Filippo anche la poesia, in quanto strumento, in quanto accidente che al poeta è toccato in sorte d'avere, è arte dell'incontro. Banale sillogismo ci porta ad inferire che senza la vita, senza il movimento talvolta amaro delle cose, la poesia è parola vuota, fine a sé stessa, che non si incarna.Incontrare gli altri, comunicare, è spesso faticoso. Implica uno spostamento non solo fisico ma anche - soprattutto - interiore. E l'immagine del cammino, della ricerca che conduce all'incontro che poi va coltivato col dono sacro della parola è carissima a Filippo. Anzi, direi che sostanzia la ragione stessa del suo ultimo libro, Una bellissima storia, dove già per sé la storia è un percorso lungo le proprie strade e per i propri luoghi. Luoghi che non sono mai concepiti come vuoti, solitari; sono intensamente abitati da mille destini che Filippo incrocia: dediche, citazioni, riferimenti alla quotidianità di una comunità rendono i suoi versi una bellissima città a misura d'uomo.
Vorrei qui fare un breve cenno, per spiegarmi e restituire l'immagine che ho avuto nel vedere i collages di Filippo, proprio alle sue composizioni figurative, dove si insiste su qualche immagine reale o appartenente alla nostra tradizione pittorica usandola come sfondo, per "incollarvi" o riprodurvi con la tecnica del fotomontaggio profili a lui noti, sagome e ritratti di persone che hanno avuto un tratto significativo nella sua vita e che rappresentano la ricerca delle sue radici. Le piazze, i locali, le stanze vuote si animano della sua gente. Della sua comunità.La medesima impressione possono darci i suoi versi con una magica suggestione evocativa e pittorica. Il suo camminare diviene tuttavia il nostro camminare, ché diversamente la poesia non si incarnerebbe. Un cammino attraverso il tempo e lo spazio, una storia di incontri, perdite, nostalgie, miracoli imprevisti e gesti minimi che poi divengono emblematici. Così, anche il tema dell'incontro può avere il duplice valore della magia e dell'incanto da una parte, della sofferenza e del distacco dall'altra. Gli incontri sono imprevisti, ci capitano tra capo e collo, proprio come i libri. Succedono, accadono senza che noi ne possiamo prevedere i tempi e la scansione. E tutto si basa su un sottilissimo e tenue filo di immagini, profumi, gesti evocativi. Un semplice tratto, una svista.
Tra simili ci si conosce al volo. / Si riconosce un tratto, una svista, / i sillogismi del cuore. Specialmentese / se poi un'ansia di coprire / fa scoprirele carte, svelare i sogni, / diciamo così. Ma è un gioco per pochi intimi e forse / una tacita complicità destinata / al suo privato oblio. / That's all.
Tutta la densità del primo verso, vitalissimo e dal profumo intenso di una invocazione, si riverbera poi nella malinconia e quotidianità del finale. That's all. Questo è tutto: come per chiudere una questione e rimandare tutto al prossimo pensiero, alla prossima poesia. Come uno scatto improvviso, uno struggimento che è già divenuto volontà di proseguire la bellissima storia verso un altro incontro. That's all.
Il rapporto con il tempo è basato su un ambiguo atteggiamento di amore e odio. Filippo lo insegue dentro l'immobilità paradossale del suo trascorrere, fra le storie dell'esistenza e la storia personale dell'esistere: un tempo immobile, catturato nell'immagine del locale dove si gioca a biliardo e che immaginiamo avvolto nella semioscurità delle luci soffuse, tra i fumi e le persone che maneggiano la stecca da biliardo, magari un bicchiere poggiato sulla cornice del tavolo.
Se Ti incontrassi davvero al Bar del tempo / forse pioverei nei tuoi occhi / ma mi risucchierebbe di là / la sala da biliardo e la fumea / che ne colora le ore. Io giocare non so: / preferisco guardare / l'attimo in cui la canna / schiocca sulla biglia color crema, / afflitto come sono dalla smania / di frenare gli istanti, di calarmi / dentro la vita (Tu che faresti?) / forse in quegli occhi Tuoi / potrei arrestare l'ansia di questa corsa / senza finale / con le tappe intermedie che si accavallano / se solo Tu abbandonando il bicchiere / apparissi per caso sull'uscio / a cercarmi di nuovo. / Ecco, allora direi / che forse non era grave scivolare / sul piano verde tra i birilli scomposti / se Tu venissi a chiedermi di andare / perché s'è fatto tardi.
La sala da biliardo, allora, diviene un bar assoluto del tempo, diventa un luogo altro e fuori dalla misura crono-logica, per seguitare a giocare coi paradossi di Davoli, un luogo nel quale si cerca con smania di frenare gli istanti (un altro paradosso: la frenesia della non frenesia); si spera, almeno si spera, di vedere comparire sull'uscio la figura di un altro incontro, in un'atmosfera cinematografica dall'intenso tratto figurativo: talché ci rimane impresso, assurdamente, il volto di un'assenza. La figura che si spera di vedere ma non si vede: se tu venissi a chiedermi di andare / perché si è fatto tardi.
Affascinante questa capacità della parola di legarci all'assenza di un'immagine, più che all'immagine stessa (se tu venissi: ma non ci sei). In questo caso, cioè, l'andare via perché si è fatto tardi è proseguire lungo il filo di una bellissima storia con niente altro che la speranza di non essere più soli. Proseguire il cammino con il desiderio di un incontro e con la speranza che l'incontro ci possa essere, al bar del tempo e in un'altra poesia. In questo caso, davvero esemplare della poesia - o, se è ancora concesso usare tale terminologia, della poetica - di Filippo, c'è il racconto della contraddizione fra il desiderio di vivere nel mondo e la difficoltà ad esserci, a sincronizzarsi con i suoi movimenti; l'evocazione di uno scotto da pagare alla lucidità con cui si osservano le cose ma che impedisce però di aderirvi completamente. Il divario tra la contemplazione e la materialità del vivere, se si vuole: o ancora meglio, il contrasto tra chi il mondo lo vive da dentro, senza poterne valutare l'interezza, e chi invece è capace di uno sguardo sintetico, da un osservatorio privilegiato e complessivo, ma che il più delle volte, non potendo viverci dentro, subisce l'esistere come la condizione di un disadattato. Ma Al bar del tempo può ancora accadere l'evento dell'incontro; c'è lo scatto miracoloso di un accadimento che poi è sempre una ricerca e una speranza che tale accadimento si verifichi, più che la sua realtà e certezza. Ed entriamo, per l'ingresso principale, dentro un altro tema di Filippo, quello di una profonda intensa religiosità che anima molte sue pagine, direi anzi tutte, anche quando non s'affaccia con evidenza. Una religiosità che da una parte gli fa sentire l'altissimo valore e la responsabilità impliciti nel fare poesia, dall'altra tributa al poeta la capacità profetica dell'intermediazione tra il qui ed ora e l'Altro come altrove da qui. La ricerca tra gli uomini diventa anche una ricerca con gli uomini per una possibilità di riscatto più ampia. Con le parole che Filippo Davoli ama dire spessissimo: la poesia è un accessorio, è strumento. Non può esistere fuori dal mondo e dalla vita che lo anima.
Ecco allora il senso radicalmente profetico della parola evocativa che galleggia nel bar del tempo: dice Davoli di aver voluto esplicitamente dialogare con il libro omonimo Il bar del tempo di Davide Rondoni: "nel testo che dà il titolo al libro l'autore accompagna Gesù Cristo al bar. Qui ho sentito affiorare un'ipotesi di incontro ulteriore nello stesso bar" (vedi nelle note in calce al libro di Davoli).
Ebbene, sono sempre contrario alle note d'autore nei libri, perché mi danno l'impressione di una certa nostalgia che l'autore stesso ha per il proprio testo, quasi di volontà a non staccarsene del tutto nel consegnarlo ai lettori. Preferisco sempre l'ambiguità, preferisco che l'autore non dia segnali e che lasci scoccare dall'incrocio tra la sua anima e quella del lettore la scintilla dell'interpretazione. Tuttavia, qui, la spiegazione di Filippo ha un senso imprevisto, perché crea, come in abisso, in una vertigine di senso, l'occasione per un molteplice incontro: tra Davide Rondoni e Cristo; tra Filippo e Davide Rondoni (o meglio, tra le poesie dell'uno e dell’altro); tra Filippo e Cristo (o il desiderio di Cristo); tra Filippo e noi e così via ricostruendo i circoli che, dal più stretto al più esterno e ampio, vanno allargandosi poco a poco come cerchi nell'acqua. E vanno restituendoci il senso della poesia che è incarnazione del verbo. La poesia diviene allora parola che ha messo immediatamente in contatto l'uomo con l'uomo e l'uomo con sé stesso e con la propria ricerca del senso che ha il vivere (o il continuare a vivere: l'incontro con Cristo evoca forse il senso di una stanchezza per il tempo materiale?) e il medesimo fare poesia.
Giovanni Cara
Un vizio di scrittura (Stamperia dell'arancio, 1998)

Quinto libro poetico di Filippo Davoli (Fermo, 1965: coinvolto in una rivista viva come la pure marchigiana "Ciminiera"), rappresenta un primo approdo di rilievo, entro una storia in deciso crescendo. A ciò giova il rapporto tra una solida cultura letteraria (con tanto di uso del latino e la memoria forte di Michelangelo poeta) e lo stupore che provoca l'intreccio di storia e natura, dentro il sublime creaturale - assieme erotico e religioso - dei corpi.
Alberto Bertoni
Alberto Bertoni
Una nuova generazione (dall'introduzione al secondo volume)
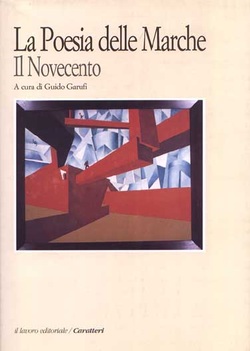
Si presentano ora alcuni testi di autori a nostro avviso interessanti. L'opzione è caduta sul piacere della lettura ma anche sulla accertata continuità della scrittura e del "lavoro" su di essa da parte degli antologizzati, convinti che proprio questo, entro certi limiti, costituisca un concreto, pur se non assoluto, "discrimine" per la scelta e la selezione, abituati (per conoscenza diretta) ad incontrare persone e libri talvolta davvero numerosi e più ancora "inespressivi": per dirla con franchezza e per lo più "privi" di quel retroterra culturale sempre necessario per "filtrare" ciò che l'emozione detta. Si voleva, insomma, in parte scommettere (come chi cura questa antologia già fece nel 1980, insieme a Remo Pagnanelli, pubblicando una congrua antologia generazionale dei "giovani" di quel tempo come Francesco Scarabicchi, Gianni D'Elia, Eugenio De Signoribus ed altri ancora, come Piersanti che, carte alla mano, hanno in un certo modo contribuito ad arricchire il panorama nazionale) e in parte affidare alla veicolazione "antologica" le loro parole. Non è proprio il caso della "ballatetta" del buon Guido, ma siamo su quell'onda, tra desiderio e augurio, anche per chi non è stato "scelto". Non se ne rammarichi troppo e pensi, se lo ritiene opportuno e vero, che la vita corre non unicamente sui fogli, ma anche sulla loro lettura e sulla pratica di una conversazione umana e civile (molte volte più "poetica" di un libro).
(...)
Filippo Davoli presenta nel suo percorso poetico la strategia della equidistanza tra esperimento prosastico e tensione musicale. Nelle prime prove ("In epigrafe", 1986) la scrittura gira ancora sul taglio epigrammatico, strutturandosi persino su blocchi aforismatici e denunciando, tuttavia, la sua "cadenza" in nota che si fa più palese nelle raccolte successive "Mal d'auto" (1990) e "Poemetti del contatto" (1994). Scrittore "ideologico", nel senso maturo e aperto, cosciente - come ha rivelato in riversi interventi critici e in interviste - del fatto che non si debba abbandonare il senso e il messaggio che spetta alla poesia e che la riguarda, per così dire, ontologicamente. Lingua poetica, allora, e "lingua per gli altri" si accorpano nelle raccolte sopra citate in un convulso (ma freddissimo quanto a lessico) circoscrivere gli eventi apparentemente minimali elevandoli al rango di occasioni universali. E' la traccia che si scorge nelle impietose diagnosi di una vita "provinciale" (è insistente e quasi ossessivo l'uso del repertorio urbano, con le sue mura restrittive, con le sue "ripetizioni", con la calsa comunicazione e i riti delle borghesi educazioni). Ma qui il testo sembra dirigersi "anche" verso un "altrove", un altro orizzonte capace di sorpassare il sequestro (si noti, in particolare, l'ascendenza-tematica-leopardianmontaliana nella esegesi del "muro" e della "siepe" da parte di Davoli chce produce una galleria di analoghi luoghi claustrofobici e occlusivi: dai vicoli, a certi impervi percorsi "dentro" la sua città). Resta la "voce" che sembra isolata e che inveve resiste imperterrita, inappagata (Manescalchi) e ancora capace di interloquire: ne sono una spia le numerose interrogazioni e la tensione ironica e parodica che costituiscono il filo rosso, fin da "In epigrafe". Se la gnomica e il verso basso e la musica altrettanto "pianissima" avevano la facoltà di strutturare una "critica della economia cittadina" (che è metonimica e analoga rispetto a quella del mondo), così la libertà di Davoli e il superamento dello stallo si esercita - a partire dalla terza raccolta fino "Alla luce della luce" (1996) introdotta da Franco Loi - nell'esercizio di una nuova "ritmica" e nell'andamento e impostazione (si vedano alcuni incipit) vicinissimi a Sereni: "musica d'angeli" che porta persino ad esiti vicini all'oltranza (Loi) o sforamenti e riprese della voce sempre più liberata dalle pastoie (e dalle cripte) del suo labirinto cittadino. Quanto più se ne distanzia, tanto più quella voce diventa persuasiva e il colloquio alto e commovente.
Guido Garufi
(...)
Filippo Davoli presenta nel suo percorso poetico la strategia della equidistanza tra esperimento prosastico e tensione musicale. Nelle prime prove ("In epigrafe", 1986) la scrittura gira ancora sul taglio epigrammatico, strutturandosi persino su blocchi aforismatici e denunciando, tuttavia, la sua "cadenza" in nota che si fa più palese nelle raccolte successive "Mal d'auto" (1990) e "Poemetti del contatto" (1994). Scrittore "ideologico", nel senso maturo e aperto, cosciente - come ha rivelato in riversi interventi critici e in interviste - del fatto che non si debba abbandonare il senso e il messaggio che spetta alla poesia e che la riguarda, per così dire, ontologicamente. Lingua poetica, allora, e "lingua per gli altri" si accorpano nelle raccolte sopra citate in un convulso (ma freddissimo quanto a lessico) circoscrivere gli eventi apparentemente minimali elevandoli al rango di occasioni universali. E' la traccia che si scorge nelle impietose diagnosi di una vita "provinciale" (è insistente e quasi ossessivo l'uso del repertorio urbano, con le sue mura restrittive, con le sue "ripetizioni", con la calsa comunicazione e i riti delle borghesi educazioni). Ma qui il testo sembra dirigersi "anche" verso un "altrove", un altro orizzonte capace di sorpassare il sequestro (si noti, in particolare, l'ascendenza-tematica-leopardianmontaliana nella esegesi del "muro" e della "siepe" da parte di Davoli chce produce una galleria di analoghi luoghi claustrofobici e occlusivi: dai vicoli, a certi impervi percorsi "dentro" la sua città). Resta la "voce" che sembra isolata e che inveve resiste imperterrita, inappagata (Manescalchi) e ancora capace di interloquire: ne sono una spia le numerose interrogazioni e la tensione ironica e parodica che costituiscono il filo rosso, fin da "In epigrafe". Se la gnomica e il verso basso e la musica altrettanto "pianissima" avevano la facoltà di strutturare una "critica della economia cittadina" (che è metonimica e analoga rispetto a quella del mondo), così la libertà di Davoli e il superamento dello stallo si esercita - a partire dalla terza raccolta fino "Alla luce della luce" (1996) introdotta da Franco Loi - nell'esercizio di una nuova "ritmica" e nell'andamento e impostazione (si vedano alcuni incipit) vicinissimi a Sereni: "musica d'angeli" che porta persino ad esiti vicini all'oltranza (Loi) o sforamenti e riprese della voce sempre più liberata dalle pastoie (e dalle cripte) del suo labirinto cittadino. Quanto più se ne distanzia, tanto più quella voce diventa persuasiva e il colloquio alto e commovente.
Guido Garufi
Alla luce della luce (1996)

Introduzione
1. L’amore mi ha condotto a questi volti. Davoli fa questa citazione tra le strofe dedicate al matematico e sinologi Matteo Ricci? Sul misticismo non spetta a me dire parole nuove. Mettersi in attesa davanti al mistero delle cose, dell’uomo, del mondo, è proprio di ogni poeta, e non solo del santo. E in tutt’e due i casi, è il solo modo per portare un vero aiuto all’uomo. Non c’è vera poesia e non c’è autentica santità senza un atteggiamento mistico, senza accostarci al silenzio, dal quale, solo, proviene la voce e la parola; nel quale, solo, si giustifica l’azione.
A me pare opportuno accostare questa citazione all’altra, evangelica, interpretata dal Cantalamessa, che si riferisce al distacco “dall’amore di Dio” che il Cristo sente angosciosamente tra gli spasimi della croce. Ecco, a me pare che tutta la poesia di Filippo Davoli sia un perenne tentativo di esprimere, nel corpo delle cose e delle esistenze, la compresenza del vuoto e del pieno, dell’oscurità e della luce – e insieme un’attitudine all’amore, che è poi anche in un poeta compassione di sé, e slancio al dialogo con l’ignoto.
Madonna mia che freddo / che bel freddo… dice un verso, ed è appunto in questa vocazione ad afferrare l’antitesi il senso del suo poetare. Cerco me / in te che non ci sei, Attendo gli esiti che non giungeranno, e così via, in un protendersi da un vuoto verso un vuoto ma nel colmo di una speranza.
2. Ne abbiamo parlato a lungo nei nostri rari incontri: la tendenza è il silenzio, un rarefarsi della parola per alludere all’evento dentro la vita. Nella poesia la parola non è mai superflua: o è strettamente ed efficacemente legata all’essenza o è voluta dal ritmo e dal metro: c’è una legge di sostanza e di musica. Per Davoli tutto ciò è quasi ovvio. Ma il poetare in lui ha anche una necessità intima, rispondere alla provocazione dello spirito, rendere scarni gli strumenti, letterari e umani, all’ardua e flebile voce che dice: Smettiamola / vado ripetendo perché l’attimo / del distacco sia almeno, almeno quello / l’unico atto d’amore azzarda nel momento del “naufragio”. Ed è questa caparbia volontà di significato e di presenza a caratterizzare la personalità del poeta e il suo “fare”, mentre, insieme, gli affiora, ben oltre l’attitudine e la preparazione letteraria, la verità dell’impotenza della parola in se stessa: Si sfanno le parole / come briciole di pane.
3. La citazione iniziale evidenzia la malinconia dell’”essere lontani da Dio” e tuttavia la convinzxione di dover amare, di confermare il primato dell’amore – che è movimento verso – la volontà di uno scambio con le creature. Ma non è questa la poesia / forse nemmeno si scrive, inizia la penultima lirica in fondo al libro. Anche Noventa raccomanda ai poeti: Serché più in là. Giacchè non nella poesia è lo scopo, pur se anche la poesia inerisce ai fini umani e divini, anzi, è necessaria alla memoria, orientamento verso il fine, sguardo a quel “più in là” che incatena il mistico. Non mi piace la “sistemazione” letteraria e non ho presunzione critica né propensione ai riferimenti e alle somiglianze. Certo, Sereni è presente in questo libro. C’è la sua ritrosia al dire ciò che intimamente lo muove, c’è il suo senso del vuoto e dello smarrimento – si pensi al “Belvedere” di “Stella variabile” – c’è la dimensione inquieta dell’altro – l’amico, la donna, il paesaggio – e c’è, soprattutto, una tradizione ermetica, malgrado sia Sereni che Davoli ne rifiutino le premesse teoriche. Del resto, sappiamo che un’epoca raccoglie le somiglianze stilistiche più di quanto appaiano ai contemporanei e indipendentemente dalle intenzioni. Ma preferisco riconoscere in Davoli quell’atteggiamento così ben espresso in una poesia postuma di Franco Fortini: Vieni tu, vieni accanto, voglio dirti / qualcosa che ricorderai, cioè la disposizione al dialogo, la costante utopia di un interlocutore, più o meno privilegiato.
4. Non possiamo tuttavia porre in secondo piano – il mio “noi” è riferito al lettore – la propensione di questo poeta a farsi medium verso l’ignoto, a oltrepassare i limiti di una convenzionale descrittività o di una mentale conoscenza. Anche la rappresentazione della materia, della natura, dei corpi, tende a svelarne le essenze, capirne i significati riposti: Fissano le tue mani le tue rose / cinte d’acqua e i tessuti che già frusciano / lievi di te, sussurra in una bella poesia, e c’è un accenno all’intelligenza delle mani e delle rose e una compenetrazione tra le creature; e sillaba più avanti: Poi, a un tratto, forzare l’uscio, darsi / una fessura sul mondo e ancora sinteticamente: Amare l’attimo prima dell’attimo di andare. Sì, rimembranza leopardiana. Ma anche l’intuizione che non è così naturale il nostro guardare il mondo, che ci si dà uno sguardo, che, come una ferita, apriamo sempre un varco tra le nostre abitudini e il nostro modo di subire la natura per, finalmente, vederlo, il mondo. Non sono gli occhi che guardano, ma noi che spostiamo lo sguardo col mutare della nostra coscienza. E quell’amare l’attimo prima dell’attimo ancora somiglia al prima del dì di festa, ma lo sposta nella continuità – non c’è festa che delude, ma un’incessante amare l’attimo prima, l’intensità di cogliere la vita e abbracciarne l’eternità. Sintomatico è quanto mi permetto di stralciare da una lettera di Filippo: “E dire che la bellezza della nostra vita sta proprio in questa precarietà, che ha la sua segreta ma incontrovertibile dimensione di dolcezza; e che, come tu sai bene, proprio dalla precarietà del nostro Io nasce la consapevolezza di essere eterni, questa fantastica e semplicissima scoperta che si rinnova ogni giorno…”. Perciò non occasionale la citazione di padre Matteo Ricci, ma una consonanza profonda, una fratellanza nell’umiltà e nella cecità visionaria della fede: E la notte veniva a perdifiato, / e cresceva domestica, annientata, / nel tuo dolore di carne e di tempo, / la pienezza di quella Luce…
Non c’è acquietamento, né consolazione! La pienezza di quella Luce non toglie il dolore, anzi lo acuisce, perché accresce la pochezza del nostro rispondere alla Sua volontà. Appunto dall’interno di una sofferenza, che la carne crea a se stessa, si scopre la pienezza, buona e immortale, della madre Luce, e la nostra impotenza a risponderle, ma anche la sua dolce benevolenza.
5. Non vorrei che le mie parole giungessero sproporzionate o inopportune alla modestia piana di questa poesia. Ma preferisco, in ogni occasione, sottolineare l’ampiezza del sentire e dei propositi entro cui si muove il poeta, evidenziare gli strati intimi di un nostro comune sentire e dialogare, tra le disperazioni che pure ci tormentano, le quotidianità che ci tengono prigionieri o di cui ci facciamo prigionieri e quegli aquiloni di speranza che ristagnano / legati a un filo che non si spezza mai. Sì, poesie d’amore per una donna, momenti sfuggiti al quotidiano, ricordi, brevi ritratti, e poi amici, la città, il paesaggio, le riflessioni. Sono tanti motivi che spingono l’uomo a dire. Ma, attraverso questa memoria del vivere, emerge un incessante richiamo, sia pure venato di malinconia o portato dal vento che sferza la solitudine, alla fiducia, al ricordo di sé, all’attenzione, al rispetto per la vita.
Franco Loi
1. L’amore mi ha condotto a questi volti. Davoli fa questa citazione tra le strofe dedicate al matematico e sinologi Matteo Ricci? Sul misticismo non spetta a me dire parole nuove. Mettersi in attesa davanti al mistero delle cose, dell’uomo, del mondo, è proprio di ogni poeta, e non solo del santo. E in tutt’e due i casi, è il solo modo per portare un vero aiuto all’uomo. Non c’è vera poesia e non c’è autentica santità senza un atteggiamento mistico, senza accostarci al silenzio, dal quale, solo, proviene la voce e la parola; nel quale, solo, si giustifica l’azione.
A me pare opportuno accostare questa citazione all’altra, evangelica, interpretata dal Cantalamessa, che si riferisce al distacco “dall’amore di Dio” che il Cristo sente angosciosamente tra gli spasimi della croce. Ecco, a me pare che tutta la poesia di Filippo Davoli sia un perenne tentativo di esprimere, nel corpo delle cose e delle esistenze, la compresenza del vuoto e del pieno, dell’oscurità e della luce – e insieme un’attitudine all’amore, che è poi anche in un poeta compassione di sé, e slancio al dialogo con l’ignoto.
Madonna mia che freddo / che bel freddo… dice un verso, ed è appunto in questa vocazione ad afferrare l’antitesi il senso del suo poetare. Cerco me / in te che non ci sei, Attendo gli esiti che non giungeranno, e così via, in un protendersi da un vuoto verso un vuoto ma nel colmo di una speranza.
2. Ne abbiamo parlato a lungo nei nostri rari incontri: la tendenza è il silenzio, un rarefarsi della parola per alludere all’evento dentro la vita. Nella poesia la parola non è mai superflua: o è strettamente ed efficacemente legata all’essenza o è voluta dal ritmo e dal metro: c’è una legge di sostanza e di musica. Per Davoli tutto ciò è quasi ovvio. Ma il poetare in lui ha anche una necessità intima, rispondere alla provocazione dello spirito, rendere scarni gli strumenti, letterari e umani, all’ardua e flebile voce che dice: Smettiamola / vado ripetendo perché l’attimo / del distacco sia almeno, almeno quello / l’unico atto d’amore azzarda nel momento del “naufragio”. Ed è questa caparbia volontà di significato e di presenza a caratterizzare la personalità del poeta e il suo “fare”, mentre, insieme, gli affiora, ben oltre l’attitudine e la preparazione letteraria, la verità dell’impotenza della parola in se stessa: Si sfanno le parole / come briciole di pane.
3. La citazione iniziale evidenzia la malinconia dell’”essere lontani da Dio” e tuttavia la convinzxione di dover amare, di confermare il primato dell’amore – che è movimento verso – la volontà di uno scambio con le creature. Ma non è questa la poesia / forse nemmeno si scrive, inizia la penultima lirica in fondo al libro. Anche Noventa raccomanda ai poeti: Serché più in là. Giacchè non nella poesia è lo scopo, pur se anche la poesia inerisce ai fini umani e divini, anzi, è necessaria alla memoria, orientamento verso il fine, sguardo a quel “più in là” che incatena il mistico. Non mi piace la “sistemazione” letteraria e non ho presunzione critica né propensione ai riferimenti e alle somiglianze. Certo, Sereni è presente in questo libro. C’è la sua ritrosia al dire ciò che intimamente lo muove, c’è il suo senso del vuoto e dello smarrimento – si pensi al “Belvedere” di “Stella variabile” – c’è la dimensione inquieta dell’altro – l’amico, la donna, il paesaggio – e c’è, soprattutto, una tradizione ermetica, malgrado sia Sereni che Davoli ne rifiutino le premesse teoriche. Del resto, sappiamo che un’epoca raccoglie le somiglianze stilistiche più di quanto appaiano ai contemporanei e indipendentemente dalle intenzioni. Ma preferisco riconoscere in Davoli quell’atteggiamento così ben espresso in una poesia postuma di Franco Fortini: Vieni tu, vieni accanto, voglio dirti / qualcosa che ricorderai, cioè la disposizione al dialogo, la costante utopia di un interlocutore, più o meno privilegiato.
4. Non possiamo tuttavia porre in secondo piano – il mio “noi” è riferito al lettore – la propensione di questo poeta a farsi medium verso l’ignoto, a oltrepassare i limiti di una convenzionale descrittività o di una mentale conoscenza. Anche la rappresentazione della materia, della natura, dei corpi, tende a svelarne le essenze, capirne i significati riposti: Fissano le tue mani le tue rose / cinte d’acqua e i tessuti che già frusciano / lievi di te, sussurra in una bella poesia, e c’è un accenno all’intelligenza delle mani e delle rose e una compenetrazione tra le creature; e sillaba più avanti: Poi, a un tratto, forzare l’uscio, darsi / una fessura sul mondo e ancora sinteticamente: Amare l’attimo prima dell’attimo di andare. Sì, rimembranza leopardiana. Ma anche l’intuizione che non è così naturale il nostro guardare il mondo, che ci si dà uno sguardo, che, come una ferita, apriamo sempre un varco tra le nostre abitudini e il nostro modo di subire la natura per, finalmente, vederlo, il mondo. Non sono gli occhi che guardano, ma noi che spostiamo lo sguardo col mutare della nostra coscienza. E quell’amare l’attimo prima dell’attimo ancora somiglia al prima del dì di festa, ma lo sposta nella continuità – non c’è festa che delude, ma un’incessante amare l’attimo prima, l’intensità di cogliere la vita e abbracciarne l’eternità. Sintomatico è quanto mi permetto di stralciare da una lettera di Filippo: “E dire che la bellezza della nostra vita sta proprio in questa precarietà, che ha la sua segreta ma incontrovertibile dimensione di dolcezza; e che, come tu sai bene, proprio dalla precarietà del nostro Io nasce la consapevolezza di essere eterni, questa fantastica e semplicissima scoperta che si rinnova ogni giorno…”. Perciò non occasionale la citazione di padre Matteo Ricci, ma una consonanza profonda, una fratellanza nell’umiltà e nella cecità visionaria della fede: E la notte veniva a perdifiato, / e cresceva domestica, annientata, / nel tuo dolore di carne e di tempo, / la pienezza di quella Luce…
Non c’è acquietamento, né consolazione! La pienezza di quella Luce non toglie il dolore, anzi lo acuisce, perché accresce la pochezza del nostro rispondere alla Sua volontà. Appunto dall’interno di una sofferenza, che la carne crea a se stessa, si scopre la pienezza, buona e immortale, della madre Luce, e la nostra impotenza a risponderle, ma anche la sua dolce benevolenza.
5. Non vorrei che le mie parole giungessero sproporzionate o inopportune alla modestia piana di questa poesia. Ma preferisco, in ogni occasione, sottolineare l’ampiezza del sentire e dei propositi entro cui si muove il poeta, evidenziare gli strati intimi di un nostro comune sentire e dialogare, tra le disperazioni che pure ci tormentano, le quotidianità che ci tengono prigionieri o di cui ci facciamo prigionieri e quegli aquiloni di speranza che ristagnano / legati a un filo che non si spezza mai. Sì, poesie d’amore per una donna, momenti sfuggiti al quotidiano, ricordi, brevi ritratti, e poi amici, la città, il paesaggio, le riflessioni. Sono tanti motivi che spingono l’uomo a dire. Ma, attraverso questa memoria del vivere, emerge un incessante richiamo, sia pure venato di malinconia o portato dal vento che sferza la solitudine, alla fiducia, al ricordo di sé, all’attenzione, al rispetto per la vita.
Franco Loi